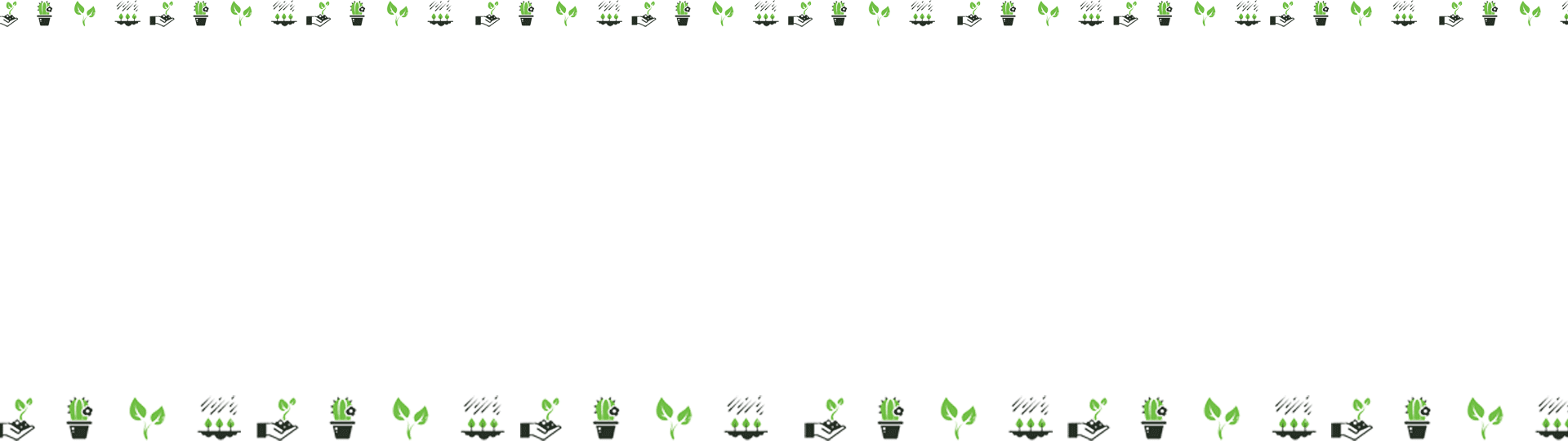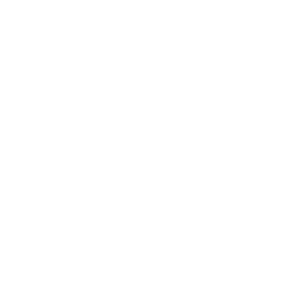Manovra, Confagricoltura: bene rinvio sugar tax ed esonero Irpef agricola ma permangono forti criticità. Le proposte di Confagricoltura
Confagricoltura accoglie positivamente all’interno del DDL Bilancio le misure sulla proroga al 2026 dell’esonero IRPEF dei redditi dominicali e agrari (c.d. IRPEF agricola) e in tema di detassazione di rinnovi contrattuali e dei premi di produttività, come pure il rinvio della c.d. sugar tax ed il rifinanziamento della Nuova Sabatini.
Lo ha dichiarato il direttore generale di Confagricoltura, Roberto Caponi, in audizione davanti alle Commissioni riunite Bilanci di Senato e Camera nell’ambito dell’esame del ddl recante il bilancio di previsione dello Stato per il 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028.
Forti criticità, tuttavia, si riscontrano sul lato degli incentivi agli investimenti. In particolare, con il ritorno al passato dell’incentivo agli investimenti 4.0 nella formula del Super ed Iper ammortamento, escludendo lo strumento del credito d’imposta, viene tagliata fuori dalla misura di incentivo per l’acquisto dei beni strumentali innovativi la stragrande maggioranza delle imprese agricole che determinano il reddito con criteri catastali e forfettari. In tal modo si arresta il percorso virtuoso che aveva caratterizzato gli ultimi anni e che aveva permesso l’innovazione tecnologica e digitale del settore agricolo.
La previsione di un contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nel settore primario appare assolutamente non idonea a compensare adeguatamente la suddetta preclusione, in considerazione della eccessiva esiguità dello stanziamento complessivo previsto per la misura di spesa pari a 2.100.000 euro sul piano nazionale (2026). Discorso analogo anche per la mancata proroga del credito d’imposta per gli investimenti delle imprese del settore primario nella ZES Unica per il mezzogiorno, che invece viene garantita per tutti gli altri settori produttivi.
Al limite della incostituzionalità si ritiene sia, infine, la previsione del divieto di compensazione dei crediti d’imposta con i debiti contributivi a partire dal 1 luglio 2026, che ledono il legittimo affidamento del contribuente che, in base alle normative di riferimento dei crediti d’imposta, ha dilazionato il recupero dei crediti in più anni. La Confederazione, confidando in un superamento delle predette criticità, auspica, inoltre, la stabilizzazione delle misure di garanzia del fondo PMI gestito Medio credito centrale per favorire l’accesso al credito delle imprese. Occorre rafforzare il tessuto imprenditoriale agricolo e agroalimentare attraverso strumenti mirati allo sviluppo e al ricambio generazionale. Necessarie politiche pubbliche incisive per favorire l’innovazione e l’accesso al credito, valorizzando anche la finanza alternativa ed essenzialefavorire l’aggregazione tra imprese, spesso troppo piccole, per migliorare la capacità di investimento e rafforzare la competitività sui mercati internazionali.
Il cambiamento climatico in agricoltura rappresenta un rischio temuto più delle oscillazioni del mercato e quasi alla pari con l’aumento dei costi di produzione. La gestione del rischio per le imprese mette in evidenza la necessità di un disegno condiviso che migliori la risposta alle avversità atmosferiche da parte delle aziende agricole. La misura del 4.0 può supportare le imprese ad effettuare gli investimenti innovativi per incrementare l’innovazione tecnologica e migliorarne l’efficienza e la produttività, con importanti ricadute positive sul c.d. “carbon farming” (cattura e stoccaggio di CO2) sui fatturati e sull’occupazione, a patto che si stanzino somme idonee a tale scopo. Con l’attuale stanziamento previsto di soli 2,1 mln. di euro è oggettivamente impossibile riuscire a garantire il percorso virtuoso della “Transizione 4.0” per il settore agricolo e a consolidare gli investimenti già effettuati, nonché a stimolare nuove aziende ad adottare le tecnologie 4.0 per dare ulteriore impulso al rinnovamento del settore.
Sul fronte energetico, inoltre, l’Italia si conferma al vertice della classifica europea per il costo dell’energia elettrica: secondo i dati aggiornati a settembre, il prezzo medio all’ingrosso del mercato del giorno prima è stato pari a 109,07 €/MWh, nonostante un calo del 3,7% su base mensile. Il confronto con i principali partner europei mette in luce un divario crescente: in Francia il prezzo medio è stato di 78,01 €/MWh (-1,7%), in Germania di 77,67 €/MWh (-13,7%), in Spagna di 69,09 €/MWh (-6,5%). La Svezia, pur avendo segnato un balzo del 44,8%, rimane la più competitiva con soli 42,4 €/MWh. Anche nei Paesi dell’Europa centro-orientale i prezzi si attestano sotto la soglia italiana: Polonia 89,64 €/MWh, Slovacchia 78,9 €/MWh, Ungheria 80,29 €/MWh.
In Italia si paga il 40% in più rispetto ai francesi e ai tedeschi, ancora di più rispetto agli spagnoli. La dinamica continentale è stata favorita dal prezzo del gas TTF che, secondo i dati ICE, ad agosto si è attestato in un range tra 34 e 35 €/MWh, con un minimo di 31,6 €/MWh negli ultimi giorni del mese: il livello più basso dall’agosto 2024. Ciò detto, va sottolineato che le piccole e medie imprese subiscono maggiormente l’effetto dei rincari anche in relazione al fatto che pagano l’energia 2,5 volte di più rispetto alle grandi aziende. Ed oggi gli unici interventi diretti a diminuire i costi energetici riguardano le imprese energivore.
Proseguire nello sviluppo delle rinnovabili per ridurre la dipendenza dal gas e impattare positivamente sul costo delle bollette, con riguardo ad alcune specificità del settore agricolo:
– continuare nello sviluppo dell’agrivoltaico e CER post 2026 e garantire che tutti i progetti approvati nel PNRR possano essere realizzati;
– mantenere lo scambio sul posto almeno per gli impianti PNRR Agrisolare e proseguire per gli altri in scadenza per tutto il 2025;
– applicare le misure in materia di CER agricole (DL 13/2023) (deroga cabina primaria, soglia 1 mw);
– priorità per accesso alle reti di elettriche per le PMI;
– risolvere il problema della saturazione virtuale della rete di trasmissione e garantire un efficace meccanismo di gestione delle richieste di connessione;
– favorire l’installazione di sistemi di accumulo;
– prevedere esenzione di accisa per i consumatori delle CER;
– mantenere la tassazione di cui al comma 423 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per il fotovoltaico a terra inserito in una CER;
– supporto all’adeguamento degli impianti per le disposizioni relative al telecontrollo;
– favorire l’utilizzo dei biocarburanti nelle macchine agricole.
Inoltre, i contratti a medio termine per acquistare energia prodotta da rinnovabili possono essere una soluzione per le imprese per ridurre l’impatto sui loro bilanci delle spese per energia.
LE PROPOSTE DI CONFAGRICOLTURA
Esaminando il testo Confagricoltura avanzq alcune specifiche osservazioni.
– Divieto di compensazione dei crediti d’imposta con i debiti contributivi. Con il primo comma dell’art. 26 del DDL si introduce, in modifica all’articolo 4-bis del D.L. n. 39/2024, conv. in L. n. 67/2024, un divieto di compensazione dei crediti d’imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte con i debiti previdenziali, di cui all’art. 17, comma 2, lettere e), f) e g), D.Lgs. n. 241/97, a partire dal 1° luglio 2026. La norma de qua si consideralesiva del più elementare principio del legittimo affidamento, peraltro sancito dallo Statuto del contribuente, ove si prevede di incidere sul diritto alla compensazione dei crediti d’imposta sorti antecedentemente all’introduzione del divieto, con effetti retroattivi sulle disposizioni istitutive degli stessi crediti che ne prevedono l’utilizzo in più quote annuali (v. credito d’imposta per investimenti 4.0 e 5.0, ecc.). Inoltre, si ritiene siano ravvisabili anche elementi di incostituzionalità per violazione dei principi di ragionevolezza, della certezza del diritto e della tutela delle posizioni legittimamente acquisite, richiedendo dunque l’abrogazione. Sul punto basti richiamare le diverse sentenze della Corte Costituzionalesull’affidamento nella sicurezza giuridica, elemento essenziale di uno Stato di diritto, che non può essere leso da disposizioni che incidono arbitrariamente su situazioni sostanziali create da leggi anteriori (cfr. tra le altre, Sent. n. 349/1985 e n. 446/2002).
– Credito d’imposta 4.0 à Il limite di spesa di 2,1 Mln. di euro, previsto dalla disposizione in esame, risulta oltremodo insufficiente laddove si consideri che la normativa sul credito d’imposta 4.0 per il settore agricolo, tutt’ora vigente, ha generato investimenti per circa 2,5 Mld. di euro (circa 1,1 Mld di crediti d’imposta), consentendo alle imprese agricole di realizzare consistenti investimenti in tecnologie avanzate, contribuendo in modo rilevante alla transizione digitale e tecnologica del sistema produttivo agricolo italiano. Peraltro,l’ammodernamento del settore agricolo necessita di ulteriori interventi per facilitare un ulteriore avanzamento tecnologico e un’evoluzione delle pratiche agricole. In questa ottica, è importante proseguire l’azione diretta a sostenere l’acquisto di una serie di beni materiali e immateriali per proseguire il percorso di innovazione avendo come obiettivo contemporaneamente quello di dare priorità agli interventi che hanno una ricaduta sulla sostenibilità e sul miglioramento delle prestazioni ambientali.
Non è un caso che la misura legata al Fondo innovazione, che ha finanziato diverse tipologie di macchine ed attrezzature agricole, abbia riscosso notevole successo. Nel secondo bando del 2024 sono state presentate 6.657 domande ed a settembre erano circa 1.850 quelle ammesse.Ciò significa che almeno 4.500 aziende nel solo anno 2024 non hanno avuto la possibilità di accedere ad incentivi per l’acquisto di macchinari. Dev’essere inoltre sottolineato che a seguito delle semplificazioni previste nell’ambito della misura transizione 5.0, con particolare riferimento all’acquisto delle trattrici agricole, anche le imprese agricole hanno avuto l’opportunità di accedere alla misura con una richiesta che è aumentata in modo considerevole nelle ultime settimane.
Nonostante il quadro descritto e la necessità di avere una programmazione pluriannuale per favorire il rinnovo del parco macchine, le proposte inserite nella DDL in esamenon tengono conto di questa necessità del settore agricolo.
La sostituzione a partire dal 1 gennaio 2026 delle attuali misure del credito d’imposta 4.0 e 5.0 (che com’è noto riguardano tutti i settori economici indipendentemente dai regimi di determinazione del reddito) con la misura del Super ed Iper ammortamento, che non trova applicazione per la stragrande maggioranza delle imprese agricole che determinano il reddito con sistemi forfettari, richiede un’analoga misura di incentivo per il settore che s’intende introdurre con l’art. 96 del DDL sotto forma di un credito d’imposta “dedicato” agli investimenti in beni strumentali per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura.
In merito al primo aspetto si evidenzia la mancanza di un dettaglio sullo stanziamento triennale che inficia la corretta programmazione degli investimenti fermo restando che si ipotizza che siano destinati circa 4 miliardi dall’attuale misura 5.0, come anche occorre una sulla disapplicazione di quei requisiti (vedi il principio DNSH) che tanto hanno limitato l’accesso ai precedenti strumenti. Per quanto concerne il secondo aspetto, la misura può supportare le imprese ad effettuare gli investimenti innovativi per incrementare l’innovazione tecnologica e migliorarne l’efficienza e la produttività, con importanti ricadute positive sulla sostenibilità sul c.d. “carbon farming” (cattura e stoccaggio di CO2) sui fatturati e sull’occupazione, a patto che si stanzino somme idonee a tale scopo. Con l’attuale stanziamento previsto di soli 2,1 mln. di euro è oggettivamente impossibile riuscire a garantire il percorso virtuoso della “Transizione 4.0” per il settore agricolo e a consolidare gli investimenti già effettuati, nonché a stimolare nuove aziende ad adottare le tecnologie 4.0 per dare ulteriore impulso al rinnovamento del settore.
Dev’essere peraltro sottolineato che in sede di consultazione con il MIMIT in settembre era stato individuato un percorso secondo il quale, nell’ambito della rimodulazione dei fondi PNRR, le risorse sarebbero state rimodulate su due tipologie di interventi:
o M1C2 – Investimento 1 – transizione 4.0 per l’extra-spesa sostenuta nel periodo finanziato dal PNRR 2020-2022 (superiore ai fondi appostati all’epoca dal PNRR); tale misura è stata inserita nel 2021 con una dotazione finanziaria di oltre 13 miliardi di euro. Negli anni la disposizione ha registrato una maggiore capacità di assorbimento rispetto allo stanziamento del PNRR, che è stata sostenuta con risorse del bilancio dello Stato;
o una nuova misura per il 2026, finalizzata a prendere il posto delle attuali Transizione 4.0 e Transizione 5.0.
Impostazione che teneva conto della necessità di proseguire l’azione portata avanti con transizione 5.0 apportando una serie di semplificazioni per renderla effettivamente usufruibile da tutte le imprese. Nel caso non dovesse essere ripristinato il percorso iniziale dando continuità agli interventi sul credito di imposta 5.0 che davano la possibilità anche al settore agricolo di accedervi, occorre come già specificato prevedere idonee risorse per assicurare nel 2026 gli investimenti delle imprese agricole in macchinari che si possono stimare in 700 – 800 milioni di euro con la necessità conseguente di prevedendo un limite massimo di spesa per il credito di imposta di almeno 300 milioni.
– Credito d’imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria à Il DDL di Bilancio prevede, all’art. 95, la proroga per gli anni 2026, 207 e 2028 del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES Unica per il Mezzogiorno, di cui all’art. 16 del D.L. n. 12/2023 conv. in L. n. 162/2023, per tutti i settori economici tranne che per quello agricolo che ha già formato oggetto di un’apposita previsione, ex art. 16 bis del medesimo decreto-legge n. 124/2023, per gli investimenti relativi agli anni 2024 e 2025. Si ritiene necessario provvedere anche per il settore primario alla concessione del credito d’imposta, analogalmente a quanto previsto in via generale per gli altri settori, per gli anni 2026, 2027 e 2028, in considerazione degli importanti effetti che la misura di incentivo ha prodotto nel biennio 2024 e 2025 in termini di sviluppo degli investimenti in beni strumentali (macchinari, attrezzature,, ecc. ), sia per le imprese agricole più tradizionali che per quelle più innovative, favorendo l’intera filiera agricola meridionale. In considerazione della risposta positiva che la misura ha generato, con circa 58 mln. di euro di richieste di crediti per il 2024, e in attesa di conoscere l’ammontare dei crediti maturati per gli investimenti da effettuarsi fino al 15 novembre 2025, si ritiene che per gli anni dal 2026 al 2028 possa ritenersi congruo uno stanziamento intorno a 60 mln. annui per il credito ZES in agricoltura che si è rivelato uno strumento di forte impatto per rilanciare gli investimenti agricoli nel SUD.
– Proroga investimenti colture arboree à Ai soli fini della determinazione della quota deducibile negli esercizi dal 2020 al 2025, a norma dell’articolo 108, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 20 per cento con esclusione dei costi relativi all’acquisto dei terreni realizzati dalle imprese agricole soggette alla determinazione del reddito d’impresa (Spa, Srl, Snc, Sas, ecc.). La proposta emendativa è diretta all’ottenimento della proroga dell’intervento incentivante anche per il triennio 2026-2028 in considerazione della tempistica necessaria per renderne concreto l’effetto della misura, in quanto gli impianti di tali colture necessitano mediamente di circa tre anni dal momento della loro ultimazione per entrare in produzione e generare ricavi.
– Criterio prevalenza à se eventi eccezionali avversi (ai sensi dell‘articolo 6, d.lgs. 102/2004) ostacolano lo svolgimento delle attività agricole, si prevede che gli imprenditori non in grado di rispettare la prevalenza dell’utilizzo dei prodotti di propria produzione, ai sensi dell’articolo 2135 c.c., mantengono ad ogni effetto di legge la propria qualifica imprenditoriale ancorché si approvvigionino prevalentemente di prodotti agricoli forniti da altri imprenditori agricoli. La proposta di emendamento riguarda una maggiore esplicitazione della locuzione “ad ogni effetto di legge”, comprendendo il mantenimento del regime fiscale proprio dell’imprenditore agricolo, di cui all’art. 32 del TUIR e 34 del DPR n. 633/72, nonché di quello previdenziale.
– Fondo di Garanzia per le PMI à proroga al 2026. La richiesta di Confagricoltura è finalizzata a prorogare l’attuale regime di intervento del Fondo di garanzia per le PMI di cui alla Legge di Bilancio sopra citata, anche per il 2026 auspicando, altresì, la necessità di stabilizzare le misure di garanzia del Fondo PMI, gestito dal Mediocredito Centrale, per favorire l’accesso al credito delle imprese.
– Esonero contributivo stabilizzazione lavoratori agricoli àunder 40. La proposta emendativa è finalizzata a rendere strutturale l’esonero contributivo strutturale per i giovani lavoratori autonomi agricoli under 40 che si iscrivono per la prima volta alla gestione previdenziale INPS. La misura proposta ricalca infatti un’analoga agevolazione riconosciuta in passato di anno in anno (da ultimo dall’art. 1, c. 503, legge n.160/2019, prorogata fino al 2023) ed ha la finalità di promuovere l’imprenditoria giovanile, riconoscendo un esonero dalla contribuzione IVS. Si stima che il costo dell’agevolazione sia pari a circa 20 milioni di euro per anno. Le disposizioni si applicano nei limiti previsti dalle regole sugli aiuti di stato.
– Fondo epizoozie, influenza aviaria e PSA à Al fine di fronteggiare le epidemie che stanno toccando vari settori zootecnici ed in particolare la recrudescenza della Peste Suina Africana negli allevamenti suinicoli, la blue tongue per il settore ovicaprino e la influenza aviaria ad alta patogenicità si prevede l’istituzione di un fondo per le emergenze zootecniche finalizzato esclusivamente alla compensazione dei danni diretti ed indiretti a favore degli allevatori colpiti.
The post Manovra, Confagricoltura: bene rinvio sugar tax ed esonero Irpef agricola ma permangono forti criticità. Le proposte di Confagricoltura first appeared on Agricolae.